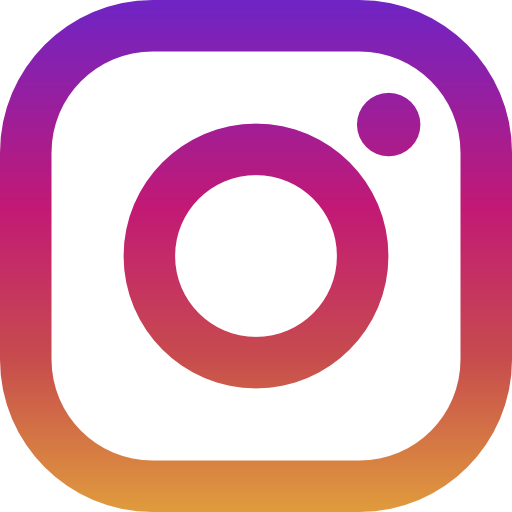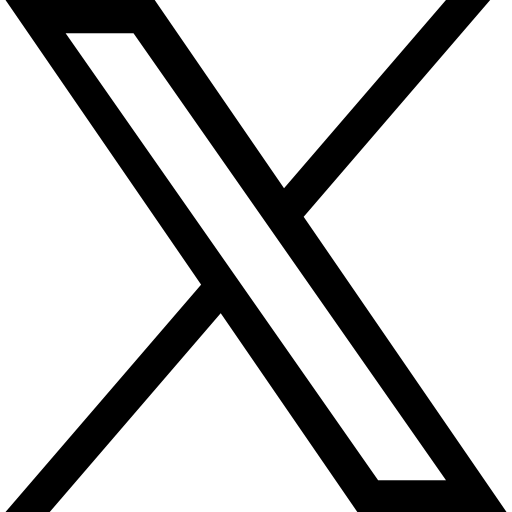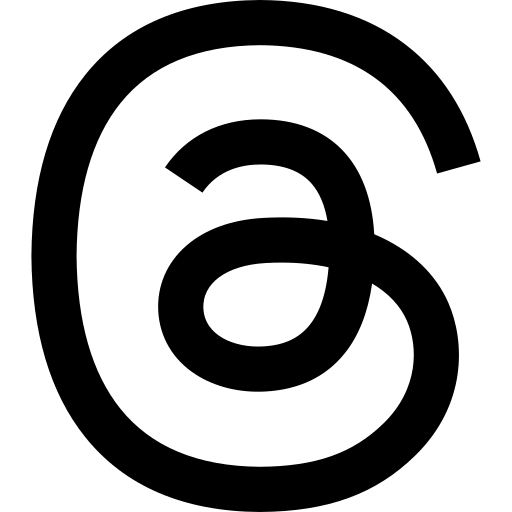Un nome molto presente sui giornali italiani da diversi giorni ci fa capire l’estrema attualità dell’odierna giornata di preghiera contra la tratta degli schiavi che si celebra oggi in occasione della festa liturgica di santa Bakhita, la santa che molto ci dice di questo nostro tempo. Sono i giornali italiani di questi giorni a farci cogliere la valenza epocale di questa giornata e di santa Bakhita con il semplice collegamento tra lei, vissuta nell’Ottocento, e le storie che si legano a quelle dei nostri giorni. La tratta sa ripetere storie e devastazioni umane che dovremmo osservare, indagare, vedere, conoscere e riconoscere.
Scrivendo di Santa Bakhita, Famiglia Cristiana ha ricordato così l’inizio della sua vicenda: “Nativa del Sudan, dove nasce nel 1869, viene rapita all’età di sette anni e venduta più volte sul mercato delle schiave. I suoi rapitori le danno il nome di Bakhita («fortunata»). […] La sua famiglia – genitori, tre fratelli e tre sorelle – abitava in un villaggio del Darfur, nei pressi del Monte Agilere. Lo zio era capo villaggio. Nata presumibilmente nel 1869, l’anno di apertura del Canale di Suez, verso gli 8-9 anni venne rapita da due arabi mentre raccoglieva erbe in un campo vicino a casa. “Se gridi sei morta” la minacciò uno armato di fucile, spingendola con violenza nella fitta boscaglia. Dopo aver camminato tutta la notte, la bambina fu rinchiusa in un bugigattolo: “Chiamavo mamma e papà”, racconterà più tardi da suora in una memoria redatta su invito della superiora, “con un’angoscia d’animo da non dire. Ma nessuno mi udiva. Di più: mi si intimava silenzio con terribili minacce”. Era talmente terrorizzata che dimenticò persino il suo nome: i due negrieri la chiamarono “Bakhita” che – ironia della sorte – significa fortunata. […] A Khartoum fu comperata da un generale turco, ma dovette subire gravi maltrattamenti dalle sue figlie e dal figlio e infine, per ordine della padrona, il supplizio del tatuaggio: una fattucchiera con un rasoio le praticò sei incisioni sul petto, 60 sul ventre e 48 su tutto il corpo, profonde circa un centimetro, dentro le quali furono messi dei grani di sale perché le cicatrici fossero sempre visibili. La ragazza rimase per diversi giorni tra la vita e la morte. Il generale prima di tornare in Turchia mise la schiava sul mercato: la prese un agente consolare italiano, tale Calisto Legnani […].»
Se sapessimo qualcosa del disastro che distrugge da anni vite infinite in Sudan per un conflitto di potere tra generali non diremmo quasi istintivamente “questa storia emerge dall’ambiente nel quale si svolge la vicenda di tante vittime come quelle di cui leggiamo sulla Libia”. In Sudan il dolore è pane quotidiano per tantissimi. Ma il rimando alla Libia certo non è infondato, o fuorviante. E allora vale la pena soffermarci sulla versione offerta da Wikipedia dell’incontro con l’Italia della giovane Bathika: “Nella capitale sudanese venne infine comprata dal console italiano residente in quella città, Callisto Legnani, con il proposito di renderle la libertà: questo diplomatico già in precedenza aveva comprato bambini schiavi per restituirli alle loro famiglie. Nel caso di Bakhita ciò non fu possibile per la distanza del villaggio di origine dalla capitale e per il vuoto di memoria della bambina riguardo ai nomi del proprio villaggio e dei propri familiari. Nella casa del console Bakhita visse serenamente per due anni lavorando con gli altri domestici senza essere più considerata una schiava. Quando nel 1884 il diplomatico italiano dovette fuggire dalla capitale in seguito alla Guerra Mahdista, Bakhita lo implorò di non abbandonarla. Insieme ad un amico del signor Legnani, Augusto Michieli, raggiunsero prima il porto di Suakin sul Mar Rosso, dove appresero della caduta di Khartum, e dopo un mese si imbarcarono alla volta di Genova”. Dobbiamo domandarci in che secolo siamo? No, credo che sia più utile domandarsi cosa accadrebbe oggi; l’ospitalità per Bathika sarebbe avversata dal senso comune di ciò che è giusto e ciò che non è giusto? Sarebbe giusto per noi, oggi? La storia di santa Bathika risale all’Ottocento, lo schiavismo appena veniva superato, noi invece viviamo nel terzo millennio, ma per chi si trova in queste condizioni il tempo sembra non passare.
Così allargando lo sguardo viene in mente una parola: esodo. Il termine “esodo” lo usiamo abitualmente in occasione del Ferragosto e della grande fuga dei “vacanzieri” dalle città, oggi riguarda più propriamente milioni di persone che fuggono da paesi devastati da bande armate, mutamenti climatici, guerre interminabili, terrorismi e narcotraffici. Le tante cause di questo “esodo” che attraversa il mondo con fiumi di esseri umani sono ormai separate dalle loro vicende di “esodati”. Questo popolo che fugge dall’invisibilità non ha una storia ma mille storie, e le mille storie di questo fiume in cammino che oggettivamente spaventa chi lo vede arrivare, interminabile, come un fiume in costante piena, le racconta la storia di santa Bakhita. Il sito della Santa Sede ricorda che a Schio, dove visse a lungo, tutti la chiamano la nostra Madre Moretta. Ma l’aspetto della sua vicenda che più colpisce è che avendo dimenticato di sé e delle sue origini sin da bambina, per la gravità degli accadimenti che la coinvolsero, Bakhita riesce con questa dimenticanza a unire in una storie tutte queste storie diverse, rende un popolo in cammino il popolo a cui dà voce con la sua santità: le vittime della tratta che non conosciamo sono lì, nel fiume, tra tutti coloro che, fuggendo, sperano.