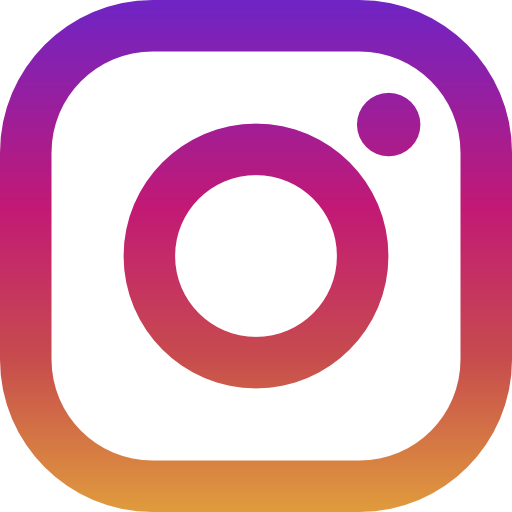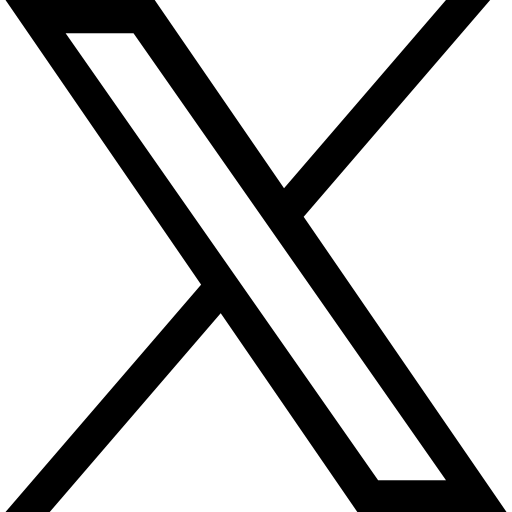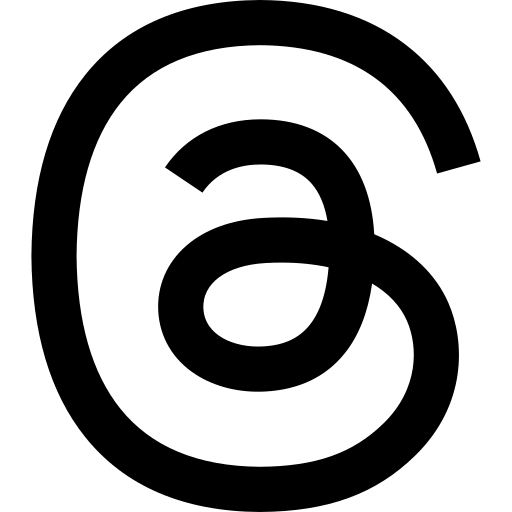Giustizia e pace sociale sono due espressioni parallele che, grazie all’impegno a 360 gradi delle comunità, si possono incontrare e fondere per realizzare un mondo più inclusivo ed attento a coloro che, in passato, hanno commesso degli sbagli. Ciò però implica il cambiamento del punto di vista collettivo, vedendo le persone per quello che effettivamente sono e non solamente attraverso i loro sbagli, nell’ottica di una ricostruzione dei legami tra le vittime dei reati, gli autori degli stessi e le loro comunità di appartenenza, come previsto dalla cosiddetta “giustizia riparativa”. Interris.it ha parlato di questo concetto e delle sue possibili declinazioni con la dott.ssa Cinzia Neglia, referente di Caritas Italiana per l’ambito giustizia.

L’intervista
Dott.ssa Neglia, come si può definire la giustizia riparativa?
“La giustizia riparativa è un modo di vedere le relazioni umane e per prevenire i conflitti in ogni sfera della vita. Il Forum Europeo ci dice che, la stessa, è un approccio volto a fronteggiare il danno o il rischio dello stesso e, di conseguenza, ha anche una finalità preventiva, coinvolgendo tutti coloro che ne sono toccati, affinché raggiungano un accordo su come, il danno o il torto arrecato, possa essere riparato ottenendo giustizia. Quindi, invece di separare le persone ed escludere quelle che sono percepite come una minaccia, i processi riparativi, ricostruiscono la protezione e la sicurezza riunendole, facendo il modo di riparare il danno subito e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo, l’intesa e l’incontro. Di fatto, è stato dimostrato che, la giustizia riparativa, è appropriata ed efficace in diversi contesti. Non solo per quanto riguarda la sicurezza o il peace building, ma anche sul fronte dell’educazione, dello sviluppo sociale nonché nella vita di ogni organizzazione e comunità. Pertanto, oltre a mettere insieme chi ha prodotto il danno e chi lo ha subito, rende più coesa la comunità che, in qualche modo, è stata partecipe al danno e deve partecipare alla ricomposizione”.
Quale può essere il ruolo della giustizia riparativa sul versante della ricomposizione dei legami all’interno delle comunità?
“La giustizia riparativa ha una funzione fondamentale su questo versante. Attraverso i suoi valori fondanti, ovvero il rispetto della dignità umana, la solidarietà, la richiesta di responsabilità personale ed il dialogo, è in grado di costruire connessioni e relazioni. All’interno di questo processo si stabiliscono delle regole e quindi si attivano delle relazioni che sono basate sulla fiducia e sulla reciproca comprensione. Tutti sanno che, ogni persona, ha bisogno di sentirsi appartenere alla comunità così come si sa che le relazioni personali positive hanno una grande influenza sul comportamento delle persone. Quindi oserei dire che, la giustizia riparativa, svolge una forte azione preventiva proprio perché, costruendo le connessioni e creando un clima che consente di mantenerle, le ingiustizie sono disfatte o, a volte, si svolge un’azione di prevenzione nel senso che, creando una rete di appartenenza e di relazione, si sostengono anche i più fragili e, di conseguenza, si neutralizzano le possibilità di commettere danni”.

Come si è esemplificato il progetto “Giustizia riparativa” di Caritas Italiana? Che obiettivi si pone?
“In questo momento abbiamo terminato la parte di progetto nazionale sperimentale che abbiamo voluto fare in otto diverse diocesi, dal nord al sud Italia, comprese le isole. Gli obiettivi sono tanti: in primis la formazione degli operatori e i volontari di Caritas a questo paradigma. Si intendeva poi far conoscere il tema della giustizia riparativa, trasmettendo e sperimentando i fondamenti, riuscendo a far acquisire delle competenze e attivando la comunità mediante la risoluzione dei conflitti. Nelle otto diocesi in cui il progetto è stato realizzato, è stato fatto molto di più di quanto originariamente si pensava. C’è stata un’emersione del bisogno: da incontri che volevano essere solo di sensibilizzazione, hanno preso avvio delle richieste di aiuto per la gestione dei conflitti”.
Dove avete operato? Che cos’è emerso dalla vostra esperienza?
“Abbiamo operato molto nelle scuole, nelle parrocchie e nei centri educativi per minori. A titolo esemplificativo, in uno di questi, partendo dalla sensibilizzazione dei ragazzi a cui si è unita quella con i genitori ove si ragionava sul rapporto tra loro e i figli, è emersa la necessità di riflettere sul rapporto di coppia. Pertanto, in ogni spazio e luogo della nostra vita, la giustizia riparativa, può aiutarci ad andare avanti e a crescere. Alcune esperienze sono state fatte anche all’interno degli istituti di pena nei quali è necessario far conoscere le opportunità, avere un modo diverso di affrontare le sofferenze, vivere le proprie responsabilità e riconnettersi con le proprie comunità al fine di poter ricostruire la loro vita. È importante acquisire consapevolezza di ciò che è stato ma andare oltre. C’è però bisogno di molta formazione da parte degli operatori. La giustizia riparativa non è facile da applicare perché fronteggia il dolore delle persone. Ma, se quest’ultimo, si affronta avendo alla base una serie di valori come, ad esempio, il rispetto e la disponibilità all’ascolto profondo e attento ai bisogni dell’altro, si possono creare nuove relazioni. È un percorso di crescita personale ed una scelta, ma è fattibile e porta a dei risultati veramente importanti”.