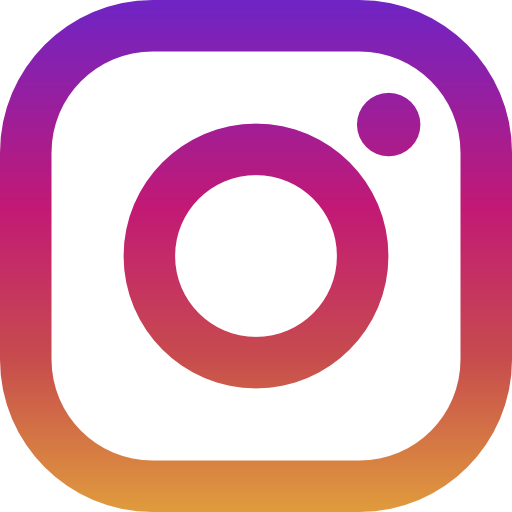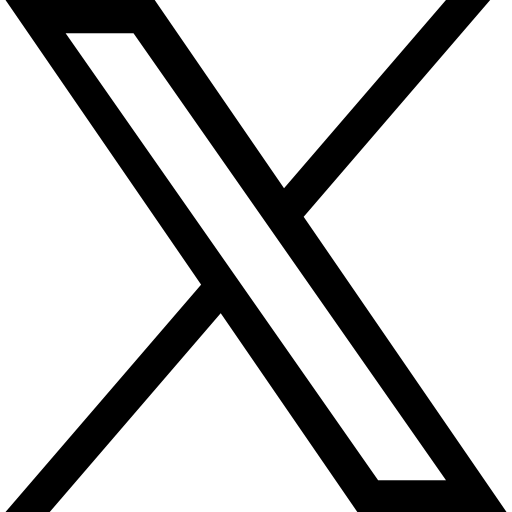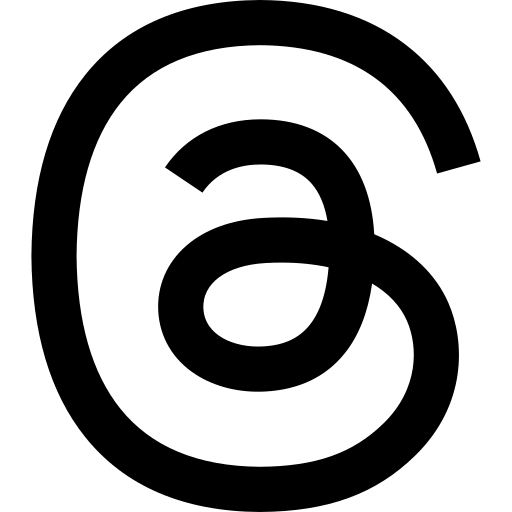È fuori dubbio che il sessantotto, inteso come movimento politico, sociale, culturale, ha rappresentato un momento di svolta epocale nel cammino dell’occidente. Le idee che hanno dapprima incuriosito e poi conquistato un’intera generazione, hanno finito per stravolgere il modo di pensare e di vivere, diventando costume e influendo in maniera determinante alla fine di un mondo (il vecchio) e all’inizio di un altro (il nuovo). Ancora oggi le idee partorite in quegli anni, determinano l’agire politico e culturale della nostra generazione, figlia della rivoluzione culturale del sessantotto.
La scrittrice e saggista Elisabetta Sala ci riporta indietro nel tempo immergendoci nel vivo di quegli anni turbolenti fatti di ideali e di promesse, di sogni e di passioni, che non sempre hanno compiuto le aspettative. Lo fa col suo romanzo Figli di ieri di recente pubblicazione (Ares 2024, pp. 310). La narrazione segue le vicende di Costantino (detto Tino) che dalle montagne di Monno, in Valcamonica, si trasferisce con la sua famiglia nella Milano degli anni 70, custodendo nel cuore il sogno d’infanzia: quello di diventare un eroe per salvare il mondo.
La novità, le sorprese e le meraviglie della città non riusciranno a cancellare in lui il ricordo costante e nostalgico della montagna e di una infanzia vissuta nella semplicità, tra amici e parenti, casa, chiesa e passeggiate tra i boschi.
“Milano era la terra complessa, il luogo delle opportunità, della sperimentazione, forse anche degli sbagli: era la chioma di una pianta sbattuta qua e là dal vento. Monno era le radici di quella pianta, infisse al suolo una volta per sempre” (p. 90). La montagna rappresentava la sua casa, ma anche quel «piccolo mondo antico” che, “con la sua immutata bellezza, era sempre lì”. (p. 88)
Il liceo Beccaria offrirà a Tino la possibilità di entrare in contatto con le nuove proposte culturali, portate avanti dai compagni e professori, estasiati dai proclami di una rivoluzione ormai in atto. Chissà che il suo sogno d’infanzia non trovi occasione di realizzarsi nel campo politico, nella lotta alle ingiustizie, ai soprusi e alle guerre di potere. Le sirene del marxismo, del femminismo e degli intellettuali di moda, cattivi maestri capaci di incantare i più, promettevano risposte alle domande profonde di una generazione travagliata, alle prese con la fine di un mondo.
Presto però dalle parole e dalle astrazioni si deve passare ai fatti. E quando la violenza prende il sopravvento nelle piazze, a scuola e persino tra amici, Costantino dovrà fare i conti con la realtà, purtroppo diversa dalle parole, dai programmi, dai sogni e dalle idee del circolo culturale che ha iniziato a frequentare.
La violenza, il tradimento, l’inganno, la dipendenza sono gli elementi di un brusco risveglio in cui il mondo interiore di Costantino, impotente, viene poco a poco “eroso dalla disperazione”. “Tutto ciò in cui credeva, era un meraviglioso palazzo di argilla pieno di crepe”.
Contemporaneamente Tino scoprirà l’amore, quello che ti fa perdere la testa e fare cose che non si immaginava di fare. Ma anche qui la realtà fa “atterrare” dolorosamente i sognatori e l’amore romantico si tramuta in dolore e passione con cui fare i conti.
Un potente romanzo di formazione che mostra come il fascino delle idee, in politica come in amore, può facilmente e pericolosamente allontanare dalla realtà. Mentre la vita, qui e ora, richiede un eroismo quotidiano che sappia conservare ciò che è buono e ciò che resta per sempre, come il gusto per le cose belle (“la mancanza di bellezza uccide l’anima dentro di noi“), l’amicizia, la famiglia e la semplicità di un impegno quotidiano che non dimentica chi cammina accanto, con le sue domande, i suoi drammi e i suoi problemi.
In mezzo a tanti stravolgimenti epocali, si apre la possibilità che “il problema principale della vita moderna non sia tanto di ordine economico o sociale quanto di ordine estetico” dove la bellezza gioca un ruolo fondamentale, da scoprire e da valorizzare.