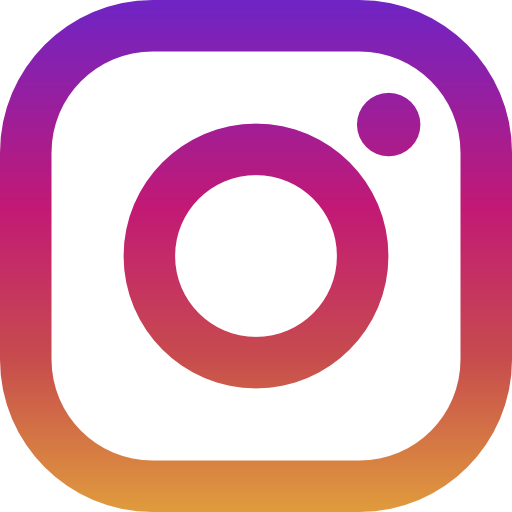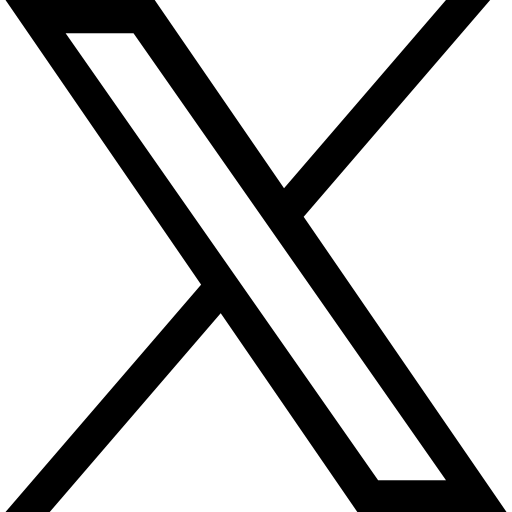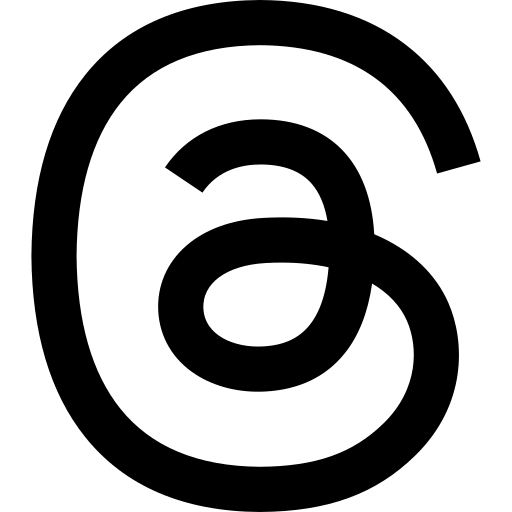Dopo ripetuti avvisi, il 6 giugno 2024 la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso, con un solo voto contrario, di limare al ribasso di 25 punti base la struttura dei tassi d’interesse, a partire da quello di riferimento, che era al 4,50% e ora è al 4,25%. Sembrerebbe una decisione marginale, se non fosse che è il primo intervento al ribasso dal 2019. La decisione è stata presa in presenza di un tasso medio di inflazione ancora superiore a quello che la BCE considera ottimale (2,6% a fronte del 2%), ma per dare un riscontro all’abbassamento drastico dell’inflazione avvenuto negli scorsi mesi. Va anche notato che la decisione della BCE anticipa quella della FED americana e non rappresenta necessariamente il primo passo verso un percorso di riduzione, che viene legato alle evidenze provenienti dall’andamento dell’inflazione.
Per la sua desiderabilità, la decisione è stata commentata positivamente da tutti i debitori, che ora possono contare su un qualche contenimento della loro spesa per mutui e altri prestiti. Come è noto, il tasso di interesse di riferimento della Banca centrale segnala il livello del costo del denaro nell’area di riferimento (l’eurozona, nel caso della BCE): tassi più alti scoraggiano gli investimenti a prestito e gli acquisti di immobili a mutuo, tassi più bassi invece li favoriscono. Di conseguenza, se si vogliono mettere in campo politiche monetarie espansive, si tagliano i tassi di interesse, ma se questo viene fatto senza prudenza, si accende l’inflazione, con i suoi impatti negativi sul costo della vita e sulla perdita di potere d’acquisto di tutti coloro le cui entrate sono poco reattive nei confronti dell’inflazione.
È allora compito delle banche centrali quello di regolare i tassi, cercando un equilibrio tra l’obiettivo di stabilità dei prezzi e quello di promozione dell’attività economica, un equilibrio che solo le banche più virtuose riescono a mantenere. Si è a lungo rimproverato alla BCE di avere solo un mandato: la stabilità dei prezzi, a causa del suo statuto di “indipendenza” che le venne imposto per evitare qualsiasi cedimento nei confronti dell’inflazione, impedendo al PIL di crescere a tassi più elevati. Ciò ha contribuito all’allargamento del gap con gli Stati Uniti, fondamentalmente generato dal monopolio che questi hanno sulla IA (Intelligenza Artificiale), ma anche dalla carenza di politiche fiscali e monetarie più espansive.
Ciò è stato in larga parte dovuto ai problemi connessi con il fatto che le politiche fiscali nella UE sono ancora nazionali e governate da regole inflessibili. Oggi, tuttavia, con il nuovo “Patto di stabilità” approvato il 23 aprile 2024, che permette di far acquisire all’Unione Europea un ruolo di coordinamento significativo delle politiche fiscali nazionali, la UE può attivare anche una responsabilità relativa al “secondo mandato”, ossia quello di promuovere l’attività economica e l’occupazione della UE con politiche condivise di spesa pubblica.
In realtà, nello Statuto della BCE (e del Sistema Europeo delle Banche Centrali, suo braccio operativo) è presente un riferimento all’appoggio alle politiche della UE (non meglio definite), ma fino ad oggi questo è stato fatto solo occasionalmente e mai esplicitato. C’è oggi chi prevede che la nuova Commissione della UE dovrà affrontare il problema di ripensare le funzioni della BCE, proprio alla luce di nuove assunzioni di ruoli da parte della UE (difesa, transizione energetica, IA) con relativa necessità di emettere altro debito europeo, che al momento è minuscolo e copre solo parte dei fondi del PNRR, e della necessità di sostenere la competitività della UE nel contesto geopolitico attuale.