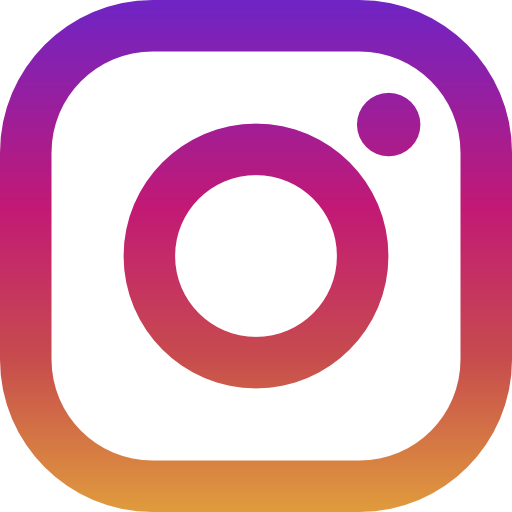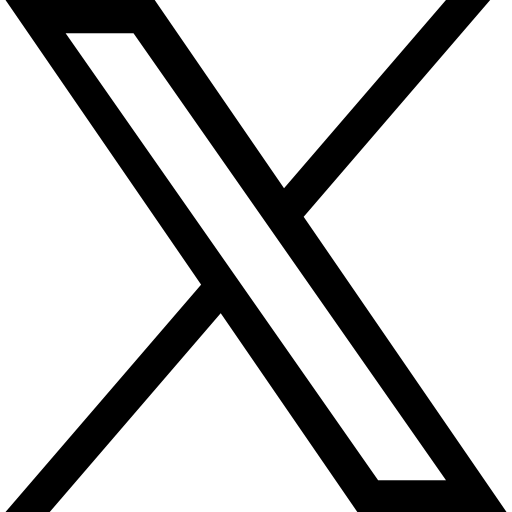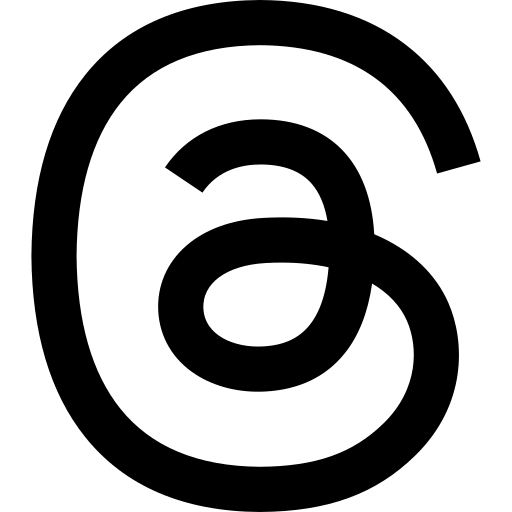Con una recente pronuncia la Consulta dichiara incostituzionale una “legge oscura” sulla base del parametro della ragionevolezza. La sentenza n. 110 del 2023 afferma, per la prima volta, che un provvedimento inintelligibile contrasta con il principio di legalità e con la parità di trattamento dei consociati. Il cuore della garanzia consacrata nell’art. 3 della Costituzione si sostanzia nell’obbligo di chiarezza della norma in modo che sia comprensibile a chi è tenuto ad applicarla e esige la rimozione gli ostacoli che si frappongono alla certezza del diritto. Infatti, le norme radicalmente opache creano le condizioni per un’applicazione diseguale della legge e sono foriere di intollerabile incertezza nella loro attuazione concreta.
Le cause della scadente qualità della normazione sono molteplici. Esse si radicano nel sistema di bicameralismo paritario che rende defatigante l’iter procedimentale. Dinanzi alla lentezza dell’iniziativa legislativa ordinaria, il ricorso ai decreti-legge rappresenta il canale di produzione normativa di maggiore attrattività sia per i Governi, perché assicura l’immediata entrata in vigore delle norme, sia per i parlamentari che possono aggiungere attraverso gli emendamenti ulteriori disposizioni in tempi rapidissimi. Per garantire una normazione spedita, si potrebbero prevedere procedure parlamentari con corsie preferenziali e decisioni a data certa.
In questo quadro si inserisce l’esigenza di porre un freno alla confusione derivante dall’abuso dei decreti-legge. Lo dimostra la tendenza in tema di decretazione d’urgenza, che da decenni ha perso il carattere di straordinarietà, divenendo lo strumento abituale di produzione normativa. Dal rapporto 2022–2023 fornito dal Comitato per la legislazione emerge come in questa legislatura su 83 leggi approvate, 40 sono di conversione dei decreti-legge.
Nel progressivo aumento delle disfunzioni delle decisioni pubbliche pesa in modo rilevante il fenomeno dello short–termism, cioè del c.d. presentismo. I sistemi liberal democratici devono fare i conti con regimi che democratici non sono e in cui il confronto con l’elettorato è solo di facciata. In tale contesto geopolitico, i leaders occidentali si concentrano sull’esigenza di favorire le domande contingenti al fine di ottenere il consenso nella successiva tornata elettorale. La politica così è fatta da scelte di corto respiro, incoraggiata anche dalle regole di comunicazione social, che allontanano dal perseguire scelte di lungo periodo per l’attuazione dei principi costituzionali.
Il Parlamento dovrà accogliere il monito della Corte, migliorando la qualità delle leggi. Il superamento dei profili critici della produzione normativa attraverso proposte per il miglioramento dei testi normativi è al centro dell’attività dei Comitati per la legislazione di Senato e Camera. Si tratta di due organi monocamerali che hanno focalizzato la prima indagine conoscitiva proprio sulle disfunzioni dei processi di produzione normativa.
Un rimedio è l’adozione di testi unici che mira a fornire un quadro normativo di riferimento chiaro e semplice destinato a cittadini ed imprese. La scelta di adottare tecniche di codificazione tramite la concentrazione in “testi unici integrati” serve ad evitare una eccessiva proliferazione delle fonti in ogni singolo ambito, orientata alla semplificazione del quadro normativo. Il divieto del gold plating, di derivazione euro unitaria, impone un adempimento in ordine alla drastica riduzione del complesso delle disposizioni. Esso si traduce in una misura volta a ridurre gli oneri non necessari, vietando l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive. Dovrebbe divenire prassi consolidata la scelta di coinvolgere anche un esperto linguistico nella elaborazione delle norme, come è avvenuto per la scrittura del nuovo Codice dei contratti pubblici. L’apporto di “saperi non giuridici” traduce l’esigenza di un coinvolgimento multidisciplinare; un’opportunità da cogliere per svolgere un lavoro certosino di sistemazione concettuale e linguistica delle norme.
Per elaborare dati e predisporre norme semplici e senza ridondanze ci sarebbe anche l’intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie potrebbero essere utilizzate a supporto del lavoro parlamentare, come si legge nel rapporto predisposto dal Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione della Camera. Un programma algoritmico potrebbe costituire un ausilio per evitare di scrivere leggi scadenti composte da un solo articolo e centinaia di commi, con rinvii a precedenti leggi, senza riportarne il contenuto ma solo numero e anno, risultando indecifrabili ai non addetti ai lavori.
Questo ovviamente non significa togliere spazio alla discrezionalità della politica, ma accompagnare il percorso di produzione delle fonti, per una legislazione scritta bene, perché si può chiedere ai cittadini di osservare leggi chiare.