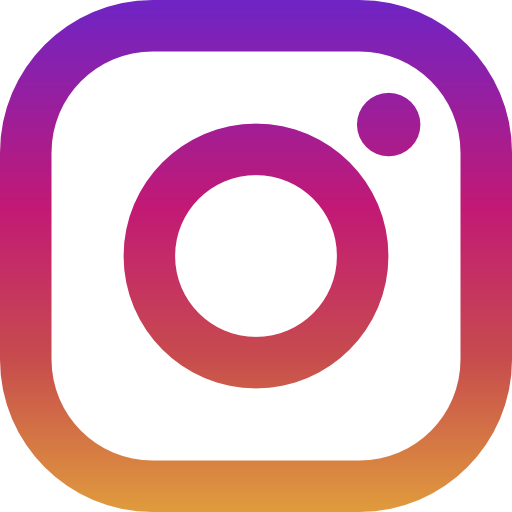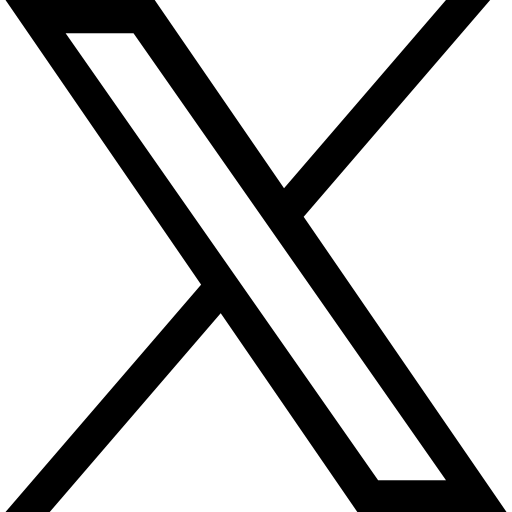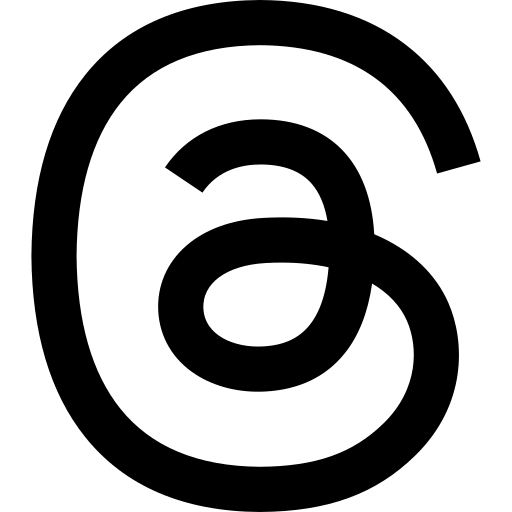Una parola racchiude Giacomo Matteotti, “parlamentarmente”. Questo avverbio coniato in risposta al presidente della Camera dei deputati che gli intimava di proseguire il suo intervento “prudentemente”, mentre nell’aula di Montecitorio teneva il suo ultimo discorso, mostra la fiducia nella democrazia e nelle sue istituzioni che ha caratterizzato la sua intera attività politica, non solo dal suo scranno parlamentare. Una lealtà a quegli ideali che affiancava il leader socialista ai più deboli della società italiana di inizio Novecento, gli faceva immaginare un’Europa unita e lo portava a denunciare il clima violento che si faceva sentire sempre di più nel Paese, in particolare alle ultime elezioni politiche nell’aprile 1924. E che gli costò la vita il 10 giugno di un secolo fa. “Matteotti è stato ucciso da elementi della polizia fascista, organizzati segretamente, che lo rapirono e lo uccisero con l’obiettivo di eliminare una voce molto scomoda per il fascismo”, ricorda a Interris.it lo storico e professore emerito dell’Università Cattolica Agostino Giovagnoli. “Sulle motivazioni ci sono molte ipotesi, ma non c’è dubbio che questa fosse la ragione di fondo. Così come sul fatto che il mandante morale, politico e storico del suo assassinio fu Benito Mussolini, che lo rivendicò nel discorso del 3 gennaio 1925”.
L’intervista
Professor Giovagnoli, cos’ha significato la morte di Matteotti per la storia d’Italia?
“E’ stato un momento spartiacque. I suoi interventi parlamentari denunciavano l’orientamento antidemocratico del fascismo e con la decisione di ucciderlo si iniziò a mettere in pratica proprio quello che il deputato segnalava. Il passaggio dalla democrazia alla dittatura non è avvenuto in modo lineare perché tra la sua morte e la fine del ‘24 ci fu una grande reazione morale di fronte all’evidente volontà dei fascisti di sopprimere ogni libertà, ma al tempo stesso gli oppositori fecero l’errore di non trovare l’unità per impedire lo sviluppo verso il regime”.
Matteotti è stato un riformista moderno, rispetto anche ai suoi contemporanei?
“La sua è stata una figura di spessore ed è di grande attualità ancora oggi. Ha rappresentato un socialismo che possedeva tutta la carica ideale ma rifuggiva quelle superficialità massimalistiche di molti dei suoi compagni, dallo stesso Mussolini che poi ruppe con il Partito socialista sull’intervento in guerra agli altri che parlavano genericamente di rivoluzione senza rendersi conto che si poteva seguire una strada radicale e riformista insieme. Lui stesso si è speso in modo intenso a livello locale nel Polesine per migliorare le amministrazioni e le condizioni concrete di contadini e operai del suo territorio, unendo l’ideale di giustizia sociale e la concretezza. La sua capacità di dialogare con persone di diverso orientamento, per esempio i cattolici, per collaborare a questi fini, è un altro tratto del suo riformismo non ideologico. Inoltre, perseguiva esplicitamente l’obiettivo europeista e la costituzione degli Stati uniti d’Europa, nella consapevolezza che l’unità europea non confligge con la sovranità nazionale”.
Allo scoppio della Prima guerra mondiale, quando l’interventismo divenne predominante, Matteotti mantenne le sue posizioni contrarie. Era pacifista?
“La posizione complessiva del Partito socialista era di neutralità, in seguito l’allora direttore del quotidiano socialista ‘Avanti’ Mussolini si schierò per l’intervento e l’idea della pace entrò in crisi anche in altri leader socialisti. Matteotti fu coerente fino in fondo, riteneva che la guerra non si fa in nome dei popoli bensì contro di loro, e che le classi popolari non hanno nulla da guadagnare dal conflitto armato”.
Il deputato socialista era rinomato per la meticolosità della sua attività parlamentare, un uomo che credeva nelle istituzioni…
“Matteotti è stato un parlamentare esemplare e ha fatto della sua attività anche lo strumento della sua battaglia per le classi più povere. La sua fiducia nelle istituzioni era espressione della solidità delle sue idee democratiche. La crisi dello Stato liberale è stata una crisi del Parlamento e l’avvento del regime fascista è passato per la soppressione del luogo della libera sovranità popolare. Ancora oggi le Camere sono il cuore della democrazia e abbiamo bisogno di politici che le rispettino e di parlamentari che ci credano fino in fondo. Il Parlamento è il luogo della sintesi delle tante voci con cui parla il popolo, dove si confrontano punti di vista diversi per cercare un incontro”.
La democrazia non va mai data per acquisita una volta per tutte?
“E’ una forma di governo che convive continuamente con chi le è ostile, il fascismo ieri e il populismo oggi. Certamente chi siede in Parlamento ha grandi responsabilità, ma i nemici della democrazia sono soprattutto esterni”.