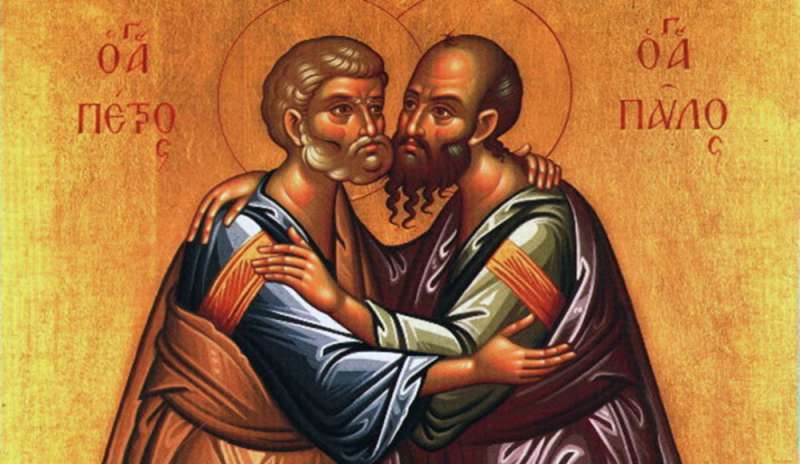Il “post-binge watching blues” è la triste conseguenza, diffusa (ma non abbastanza conosciuta) in tutto il mondo connesso di questi ultimi anni, che colpisce il telespettatore giunto al termine di una serie tv, perché non più “ispirato” e “guidato” dai suoi beniamini. Tradotta con “depressione della fine serie”, lascia la persona in uno stato di sconcerto e di disorientamento; segue il fenomeno, crescente e molto diffuso, del “binge watching”, l’“abbuffata di visione”, in genere collegata alle serie tv: si origina, quindi, nel telespettatore dipendente, nel momento in cui termina la sua serie televisiva preferita. Il problema è inquietante poiché dimostra un vuoto interiore, solo illusoriamente colmato dalla passiva osservazione di situazioni vissute da altri.
La dipendenza
Le prime avvisaglie si avvertono durante la visione dell’ultimo episodio, in cui il telespettatore/maratoneta è consapevole che si sta compiendo l’atto conclusivo e si è sul punto di lasciare i propri beniamini idolatrati, venerati e invidiati. L’argomento lo aveva introdotto un articolo del giornalista Matthew Schneier, pubblicato il 5 dicembre 2015 sul New York Times (visibile al link https://www.nytimes.com/2015/12/06/fashion/post-binge-watching-blues.html), dal titolo “The Post-Binge-Watching Blues: A Malady of Our Times”, definendo il fenomeno come “una malattia dei nostri tempi”. La dipendenza dal “binge watching” giunge, a volte, a livelli esagerati tanto da sacrificare le normali attività quotidiane, comprese quelle lavorative o di studio. Esercitato di solito in solitudine, conduce, inoltre, a sacrificare una normale vita sociale e a chiudersi in sé. Tale ritiro dal mondo, dal prossimo e dalla realtà, comporta ripercussioni mentali e fisiche.
Il fenomeno
Il peso delle tv streaming è sempre in crescendo e ha avuto un’accelerazione nel periodo del lockdown in cui, la permanenza forzata in casa, ha favorito gli abbonamenti alle piattaforme del settore. Queste mirano ad aumentare il numero degli abbonati e, al tempo stesso, a minimizzare le locuzioni che riguardano abbuffate e maratone televisive, a cui si associano stili di vita non salutari. Il fenomeno ricorda, un po’ da lontano, quello che avviene, per alcuni, al termine della lettura di un libro (sebbene questa sia una funzione attiva). I romanzi, infatti, catturano il lettore e lo trasportano nel mondo dei personaggi coinvolti, considerati nei loro aspetti, positivi e negativi, nelle loro storie edificanti o, al contrario, diseducative.
I rischi
Il pendolo, anche in questo caso, si muove tra la semplice malinconia dovuta all’interruzione di una storia avvincente e la profonda tristezza interiore che, oltretutto, tende a idolatrare ciò che si è perso senza concedere, ad altri libri (o serie tv), di essere all’altezza né di contenuti né di emozioni. Il rischio peggiore, per chi soffre di questa depressione, è il tentare di risolverla iniziando a seguire un’altra serie tv. Si configura, così, una fattispecie simile a quella di chi utilizza sostanze stupefacenti e che, non riuscendo a smettere, deve consumare altre dosi. L’illusione è quella di “dimenticare” i vecchi personaggi con alcuni nuovi, per i quali ci si promette di non innamorarsi ma il rischio è il ripetersi di situazioni già vissute. Già nel 1994 (Messaggio del 24 gennaio per la XXVIII Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali), San Giovanni Paolo II, riconoscendo i meriti del mezzo televisivo, ammoniva sui rischi “La televisione può arricchire la vita familiare: può unire tra loro più strettamente i membri della famiglia e promuovere la loro solidarietà verso altre famiglie e verso la più vasta comunità umana; può accrescere in loro non solo la cultura generale, ma anche quella religiosa. […] La televisione può ancora avere effetti negativi sulla famiglia anche quando i programmi televisivi non sono di per sé moralmente criticabili: essa può invogliare i membri della famiglia a isolarsi nei loro mondi privati, tagliandoli fuori dagli autentici rapporti interpersonali, ed anche dividere la famiglia, allontanando i genitori dai figli e i figli dai genitori”.
In libreria
La narratrice Alessandra Caneva e le professoresse Claudia Caneva e Cecilia Costa sono le autrici del testo “L’immaginario contemporaneo” (sottotitolo “La grande pro-vocazione delle serie tv”), pubblicato da “Mimesis” nel novembre 2018. Parte dell’estratto recita “L’immaginario contemporaneo, oltre a far rientrare in una ‘zona d’ombra del sociale’ la morte e le ansie antiche, fa trapelare inedite angosce e ibridazioni che derivano dalle nuove frontiere genetiche, dalla contaminazione con il mondo artificiale, e sembra mettere in discussione la stessa costruzione dell’identità soggettiva”.
Alcuni dati
Il 26 marzo scorso, a Palazzo Montecitorio, è stata presentata la Relazione Annuale 2024 “70 anni di TV, 40 anni di Auditel”, visibile al link https://www.auditel.it/wp-content/uploads/2024/03/Relazione-Auditel-2024_REV_DEF.pdf. Fra i numerosi dati, si legge “Rottamati 40 milioni di apparecchi con tubo catodico, oggi il Paese è popolato da ben 120 milioni di schermi digitali – di cui oltre 97 milioni connessi […] Nella stagione televisiva 2022-2023 i broadcaster italiani sono riusciti a crescere nella Total Audience (+1,4% rispetto alla stagione precedente), hanno raggiunto giornalmente oltre il 90% dei telespettatori e hanno conquistato l’82,3% del totale del tempo dedicato alla visione TV […] Alle 7 storiche emittenti pubbliche e private se ne sono aggiunte ben 373, per un totale di 380 canali TV oggi rilevati da Auditel. […] Oggi sul mercato globale dello streaming – che vale 154 miliardi di dollari – operano 27 diverse piattaforme. Nel 2012 c’era solo Netflix”.
Gli effetti indesiderati e la dipendenza
La partecipazione e l’immedesimazione con i personaggi della serie, conduce a identificarli come delle persone care: un amico, un parente, un partner. Al termine dell’ultima puntata, si elabora un vero e proprio “lutto” e si soffre la mancanza della persona. Si tratta degli effetti indesiderati relativi a una nuova dipendenza, di una “new addictions”, come altre legate alla schiavitù del cellulare, dell’attività fisica, ecc. Il paradosso è che all’abbuffata televisiva non segua una condizione di benessere e felicità, bensì una severa depressione. A un fenomeno di dipendenza, si associa il suo deleterio effetto, mentale e fisico. La dipendenza televisiva, nel caso specifico delle serie tv, dà luogo, a volte, a una vera e propria astinenza, con i disturbi classici, a livello psicologico, legati ad ansia, irrequietezza, alterazioni dell’umore, depressione. Il consumo di una sostanza o di un comportamento, da abitudine diventa necessità e, in difetto di autocontrollo, arriva a forme estreme di assoluto bisogno.
La teledipendenza
La diffusione della teledipendenza, al di là delle motivazioni che possano favorirla, dimostra, senz’altro, un effetto opposto, contrario, alla socialità. Le due polarità, infatti, spingono fra loro, come vettori: più elevata è la socialità più, necessariamente, si riduce la teledipendenza (e altre forme di schiavitù) e viceversa. L’isolamento sociale, in cui ci si abbandona sul divano, produce i danni fisici legati all’estrema sedentarietà che possono proseguire e trasformarsi in quelli tipici della depressione. Arrecare squilibrio ai ritmi circadiani, alterando il ciclo sonno/veglia è un ulteriore minaccia alla salute psicofisica. Anziché approfondire le relazioni reali, nella loro dinamicità non sempre lineare e desiderabile, si preferisce scivolare verso un contatto passivo e virtuale con i personaggi televisivi, ritenendolo, inconsciamente, più sicuro e a prova di delusioni. L’aspettativa, molto ampia, riservata a situazioni di comfort zone, in cui non patire (ed essere costretti ad accettare) i “continui” inganni e tradimenti della vita reale, si scontra, tuttavia, con l’ansia che sopraggiunge alla fine delle puntate. La sicurezza assoluta e le certezze inequivocabili a cui si tende, crollano anche in questa circostanza.
Chi viene colpito
La sensazione di tristezza di termine della serie, si associa anche a un richiamo alla realtà quotidiana, al lasciare quella situazione di serenità e di fuga dai problemi quotidiani, in cui il divano, il mangiare e il bere sono la cornice e la ciambella di salvataggio. Per alcuni, la serie tv offre l’occasione per costruire la propria personalità a emulazione di uno dei protagonisti; terminati gli episodi, l’individuo si trova solo, in una situazione di vuoto in cui non possiede elementi per la costruzione del proprio “io”. Il disagio riguarda sia i giovani sia gli adulti. Per gli adolescenti, alle prese con la comprensione del mondo, i personaggi presentati tendono a essere un punto di riferimento; a volte quasi unico se manca la presenza (e il filtro) genitoriale. La rapidità di fruizione degli episodi, a effetto maratona (ore e ore nella stessa giornata), non consente di metabolizzare, e commentare, contenuti e discorsi, per cui si fagocita tutto e, nel momento del traguardo, nel minestrone delle idee non si è in grado di discernere e si prova tristezza.
Un approccio più equilibrato
Si rifugge il prossimo per circondarsi di quello virtuale e amico a cui approcciarsi passivamente ed evitare, con assoluta certezza, le delusioni; tuttavia non si può pretendere di esserne esenti se, poi, queste, come appurato, giungono al termine. Un approccio più equilibrato consiste nell’accettare l’altro con le proprie caratteristiche, piacevoli e meno interessanti, puntando tutto sul dialogo: da quel confronto vero, reciproco e costruttivo, possono appianarsi e risolversi i dubbi; da quello preconfezionato dei film si torna diffidenti, asociali, insoddisfatti, chiusi e ancora più convinti di una comunità ostile quando, in realtà, non è così.